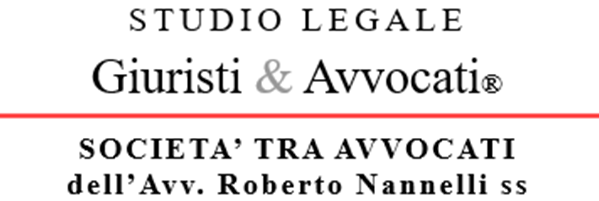Cass. Sez. Un., 23.2.2023 n. 5657
Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – canoni – interessi – indicizzazione – clausola – natura
La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98. Il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà.